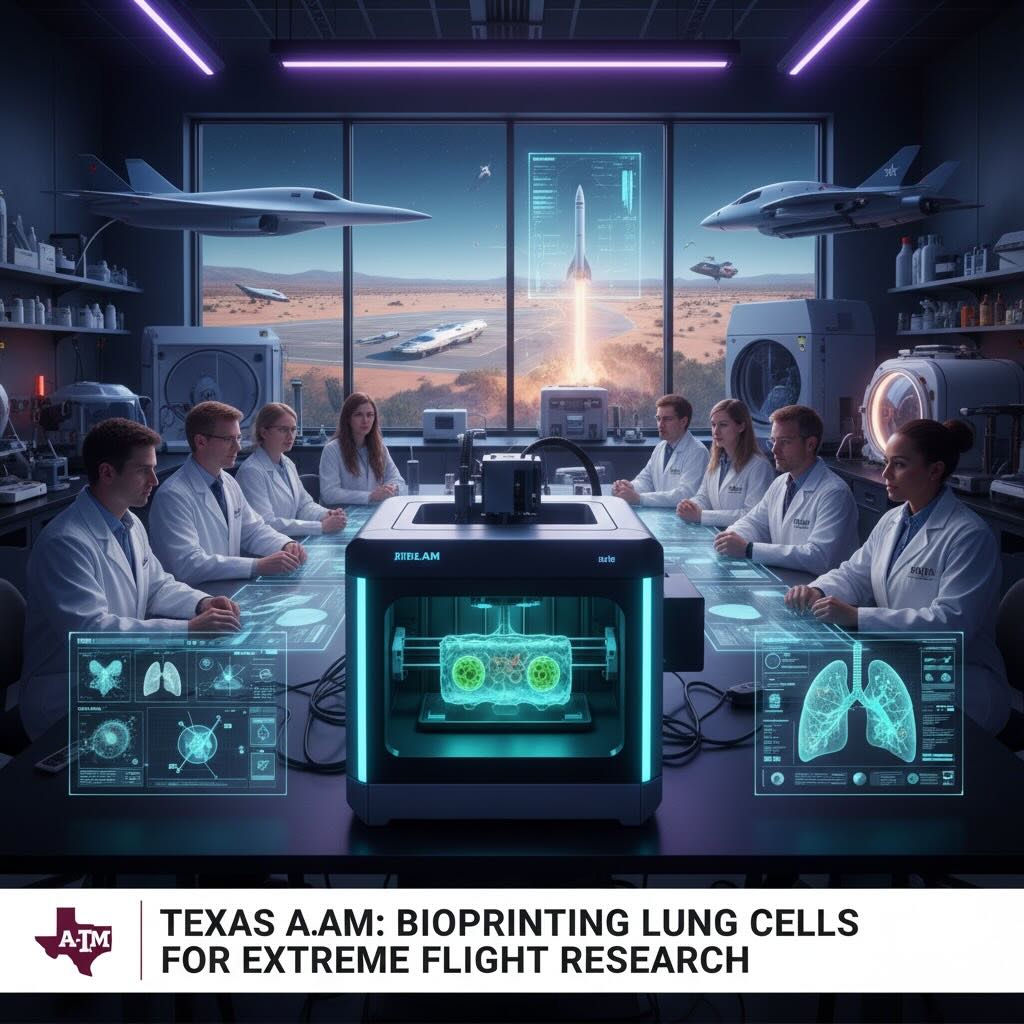Biostampa 3D per capire cosa succede ai polmoni in volo estremo
Volare ad alta quota o viaggiare nello spazio significa esporre il corpo umano a variazioni intense di pressione, temperatura e disponibilità di ossigeno. Le colture cellulari tradizionali in 2D non riescono a ricreare queste condizioni in modo realistico, e questo limita la possibilità di capire come reagiscono davvero i tessuti respiratori. Un gruppo di ricercatori della Texas A&M University ha sviluppato un approccio basato sulla biostampa 3D per modellare con maggiore precisione il comportamento delle cellule delle vie aeree in ambienti di volo estremi.
Un progetto congiunto tra ingegneria, biologia e difesa
Il progetto è guidato da Zhijian “ZJ” Pei, professore al College of Engineering di Texas A&M, in collaborazione con Hongmin Qin, biologo del College of Arts and Sciences. Il lavoro è finanziato dall’U.S. Air Force Office of Scientific Research, a testimonianza dell’interesse strategico per la sicurezza del personale di volo e degli astronauti. L’obiettivo è duplice: da un lato comprendere meglio come le cellule delle vie aeree reagiscono a sollecitazioni termiche e meccaniche; dall’altro creare modelli di tessuto respiratorio più realistici per studiare patologie e possibili terapie.
Perché servono modelli 3D delle vie aeree
Le colture cellulari tradizionali, cresciute in monocstrato su piastra, sono molto lontane dalla complessità di un tessuto respiratorio: mancano gradienti di ossigeno e nutrienti, geometrie tridimensionali, interazioni meccaniche più realistiche. La biostampa 3D permette invece di organizzare cellule e biomateriali in strutture tridimensionali che imitano meglio l’architettura delle vie aeree, compresa la barriera epiteliale e il microambiente extracellulare. Questo rende più attendibili le misure di vitalità, proliferazione e risposta allo stress rispetto a un semplice strato di cellule su vetro.
Bioink a base di collagene e alginato per cellule polmonari
Nel lavoro della Texas A&M i ricercatori usano un bioink gelatinoso che combina matrici polimeriche e cellule vive delle vie aeree. Le cartucce di bioink vengono caricate nella bioprinter e depositate strato dopo strato, costruendo piccoli costrutti tridimensionali popolati da cellule polmonari. Il team ha ottimizzato in particolare una miscela collagene:alginato in rapporto 4:1, che garantisce un buon compromesso tra stabilità meccanica, porosità e sopravvivenza cellulare. Con questa formulazione è stata mantenuta una vitalità dell’85% dopo sei giorni, un dato rilevante se si considera l’esposizione a condizioni ambientali impegnative.
Riprodurre pressione, temperatura e stress ossidativo del volo
Per simulare le condizioni estreme di volo – dall’alta quota al volo spaziale in orbita bassa – i ricercatori sottopongono i costrutti biostampati a combinazioni controllate di variazioni di pressione, incrementi di temperatura fino a circa 55 °C e condizioni di ossigenazione alterata. I risultati sperimentali mostrano che pressioni di estrusione più elevate durante la stampa e temperature più alte aumentano lo stress ossidativo nelle cellule e ne riducono la sopravvivenza. Le immagini in fluorescenza evidenziano chiaramente che, al crescere della temperatura applicata ai costrutti tridimensionali, le cellule presentano segnali di stress sempre più marcati e una ridotta vitalità, illustrando la sensibilità dei tessuti respiratori a combinazioni di calore, pressione e ipossia.
Conseguenze fisiologiche per piloti e astronauti
I risultati sperimentali hanno ricadute dirette sulla comprensione dei rischi che corrono piloti e astronauti. Cambi di quota e di pressione possono favorire accumulo di fluidi nei polmoni, mentre combinazioni di calore e sforzo fisico aumentano la probabilità di colpi di calore, danni tissutali e disfunzioni d’organo. Utilizzando modelli tridimensionali biostampati di vie aeree, il team può misurare in modo più fine soglie di stress oltre le quali le cellule iniziano a perdere vitalità o a cambiare fenotipo. Queste informazioni possono alimentare linee guida operative, limiti di esposizione e requisiti per sistemi di supporto vitale in cabina e in orbita.
Ottimizzare i parametri di biostampa per non danneggiare le cellule
Un punto chiave del lavoro è mostrare quanto la qualità del processo di biostampa pesi sul risultato biologico. Piccole variazioni di pressione di estrusione, velocità di deposizione e temperatura dell’ambiente di stampa possono cambiare in modo significativo la percentuale di cellule vive, la loro capacità di proliferare e la risposta a stimoli esterni. Parametri troppo aggressivi portano a maggiore morte cellulare e livelli più alti di marcatori di stress ossidativo, mentre una finestra operativa ben individuata consente di preservare l’architettura del costrutto tridimensionale mantenendo alti livelli di vitalità. Questo tipo di mappatura dei parametri è essenziale se si vuole usare la biostampa come strumento riproducibile per test preclinici.
Verso modelli avanzati di malattie respiratorie
Oltre alla sicurezza aerospaziale, i ricercatori vedono in questi modelli tridimensionali delle vie aeree una piattaforma per studiare malattie come BPCO, fibrosi polmonare, infezioni virali e altre patologie respiratorie croniche. La possibilità di controllare in modo indipendente fattori come pressione, temperatura e ossigenazione, mantenendo un microambiente tridimensionale vicino al tessuto reale, rende questi costrutti utili per analizzare meccanismi di danno epiteliale e riparazione, confrontare la risposta a differenti farmaci e sviluppare protocolli di medicina personalizzata. In prospettiva, modelli così dettagliati potrebbero affiancare o ridurre l’uso di modelli animali in alcune fasi di sviluppo di farmaci respiratori.
La biostampa nello spazio: Redwire, SpaceX e AstroCardia
Il lavoro di Texas A&M si inserisce in un panorama più ampio di medicina spaziale basata su produzione additiva. Esperimenti come la biostampa di un menisco umano sulla Stazione Spaziale Internazionale da parte di Redwire, con rientro del campione grazie a una missione SpaceX, o il progetto AstroCardia portato avanti da un consorzio di aziende e centri di ricerca europei per studiare l’invecchiamento del cuore in orbita, mostrano che la biostampa di tessuti umani è già parte di una strategia più ampia di ricerca in microgravità. I modelli polmonari biostampati della Texas A&M aggiungono un tassello specifico sulle vie aeree e sulle condizioni di volo estremo.
Prospettive: da modello sperimentale a piattaforma standardizzata
Guardando avanti, questo tipo di biostampa rappresenta un primo passo verso tessuti polmonari ingegnerizzati più complessi: integrazione di diversi tipi cellulari nello stesso costrutto, uso di microfluidica e organ-on-a-chip per aggiungere flussi e cicli di pressione più realistici, protocolli di lunga durata per simulare esposizioni ripetute tipiche delle carriere di piloti e astronauti. Se questi modelli diventeranno abbastanza robusti e riproducibili, potrebbero affiancare protocolli consolidati nella valutazione di dispositivi, equipaggiamenti o nuovi farmaci destinati all’ambito aerospaziale e respiratorio.