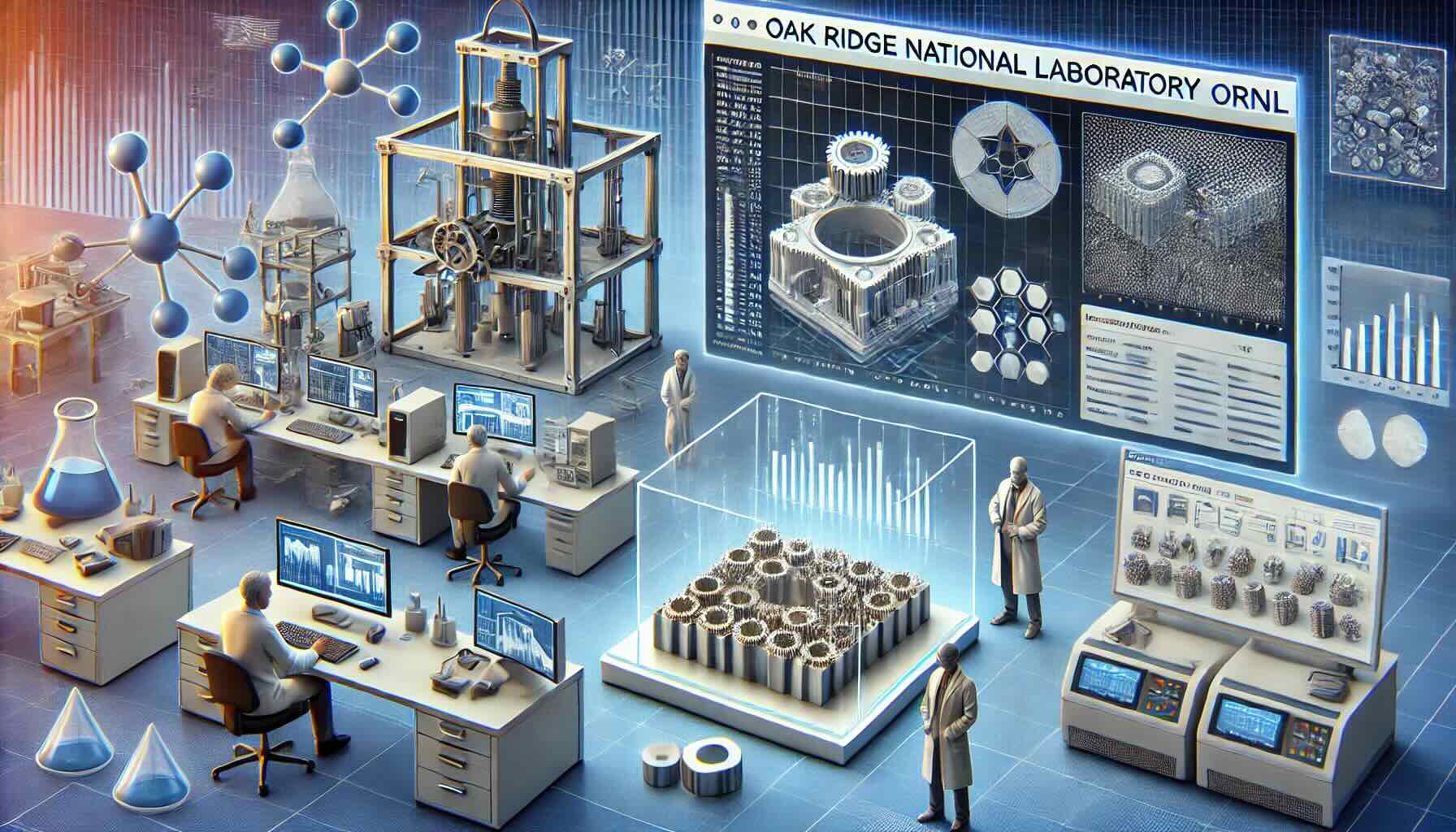HFIR: il reattore di Oak Ridge come sorgente di neutroni per analizzare i materiali della stampa 3D
All’Oak Ridge National Laboratory (ORNL), gestito dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), il High Flux Isotope Reactor (HFIR) è uno strumento centrale per lo studio dei materiali. Il suo ruolo non riguarda più soltanto leghe tradizionali, ceramiche e polimeri, ma include in modo sempre più sistematico anche componenti realizzati con produzione additiva. Il reattore, da 85 megawatt termici, opera in cicli di circa 24 giorni e fornisce un flusso continuo di neutroni ad altissima intensità, adatto a esperimenti di diffrazione e imaging che permettono di analizzare la struttura interna di materiali complessi, inclusi pezzi stampati in 3D.
Un reattore di ricerca con uno dei flussi neutronici più intensi al mondo
L’HFIR è un reattore di ricerca ad acqua leggera, progettato per generare uno dei più alti flussi di neutroni stazionari al mondo. Dal punto di vista ingegneristico, il cuore del reattore è racchiuso in un vessel in pressione di circa 2,4 metri di diametro, immerso in una grande piscina d’acqua che contribuisce sia al raffreddamento sia alla schermatura dalle radiazioni. Il reattore opera a 85 MW termici, con un flusso d’acqua di circa 16.000 galloni al minuto che attraversa il vessel e asporta il calore generato in core.
Il combustibile è costituito da piastre curvate ad alto arricchimento in uranio-235, disposte in modo da garantire canali di raffreddamento uniformi e un profilo di potenza controllato. Intorno al combustibile, un riflettore in berillio rimanda verso il core molti dei neutroni che altrimenti sfuggirebbero, contribuendo a mantenere l’elevata reattività del sistema e a generare il flusso necessario agli esperimenti scientifici. Questo schema costruttivo, unito alla gestione ciclica del combustibile, permette di alimentare per tutto l’anno esperimenti di diffusione e imaging neutronico su materiali molto diversi, dai metalli alle biostrutture.
Perché i neutroni sono così utili per la stampa 3D metallica
Per la stampa 3D di metalli e superleghe, i neutroni offrono un vantaggio fondamentale: sono in grado di penetrare spessori significativi di materiale, anche di leghe molto dense, e sono estremamente sensibili a elementi leggeri come l’idrogeno o l’acqua. Questo consente di:
-
individuare porosità interne e difetti di legame in componenti stampati con Laser Powder Bed Fusion (LPBF) o Directed Energy Deposition (DED);
-
misurare tensioni residue e deformazioni interne che si generano durante i cicli di riscaldamento/raffreddamento del processo additivo;
-
seguire trasformazioni di fase e variazioni di microstruttura in funzione dei parametri di processo o dei trattamenti termici.
Dati di questo tipo sono essenziali per costruire finestre di processo affidabili, definire trattamenti termici mirati e, in prospettiva, qualificare componenti additivi destinati a settori come aerospazio, energia e impiantistica chimica.
Una rete di strumenti per diffrazione e imaging: dai fasci caldi ai neutroni freddi
Nel complesso HFIR è disponibile una collezione di strumenti neutronici che copre sia la diffusione elastica (diffrazione) sia l’imaging radiografico e tomografico. In totale si parla di una dozzina di beamline dedicate, con configurazioni differenti per energia, geometria del fascio e tipologia di rivelatori.
Per quanto riguarda specificamente la produzione additiva, due famiglie di tecniche risultano particolarmente utili:
-
Diffrazione neutronica per tensioni residue
Diffrattometri ad alta intensità per l’analisi dello sforzo interno consentono di mappare le tensioni residue all’interno di pezzi stampati in 3D, punto per punto, anche lungo spessori elevati. Alcuni strumenti di terza generazione, sviluppati per l’analisi delle tensioni, sono stati progettati tenendo conto delle geometrie complesse tipiche dei componenti additivi. -
Imaging neutronico e tomografia (ad esempio la stazione MARS)
Stazioni di imaging collegate ai fasci del reattore HFIR offrono radiografia e tomografia neutronica 3D per studiare la distribuzione di pori, difetti, canali interni e percorsi di flusso in componenti additivi complessi. Nel caso di turbine o canali di raffreddamento interni realizzati con stampa 3D, queste tecniche permettono di verificare in modo non distruttivo che la geometria interna corrisponda al progetto.
In parallelo, al vicino impianto Spallation Neutron Source (SNS) di ORNL, strumenti come il diffrattometro VULCAN vengono utilizzati per studiare in dettaglio le superleghe stampate, creando un ecosistema HFIR+SNS a disposizione della ricerca e dell’industria.
Dai superalloy alle leghe per ambienti estremi: cosa si studia al HFIR
Molte attività di ricerca collegate alla stampa 3D si concentrano su superleghe a base di nichel e materiali per ambienti estremi, caratterizzati da alte temperature, forti gradienti termici e condizioni corrosive.
La combinazione di imaging neutronico e diffrazione su componenti stampati permette di:
-
caratterizzare la distribuzione delle tensioni residue in superleghe stampate con processi laser;
-
correlare queste tensioni con le condizioni di processo (potenza del laser, velocità di scansione, strategia di riempimento) più che con la sola composizione chimica;
-
dimostrare come specifici trattamenti termici possano ridurre in modo significativo le tensioni indesiderate, migliorando resistenza a fatica e stabilità dimensionale.
Questi risultati sono alla base dello sviluppo di superleghe stampate più robuste e meno costose da produrre, pensate per turbine, componenti energetici e parti esposte a condizioni gravose. Le stesse metodologie vengono estese a leghe ad alta entropia (HEA), titanio e acciai inossidabili avanzati, con l’obiettivo di definire linee guida chiare per la progettazione di materiali specifici per la produzione additiva.
Oltre la microscopia: neutroni come strumento di qualifica di processo
Per le aziende che lavorano con la stampa 3D metallica, una delle sfide principali è dimostrare in modo quantitativo che un processo additivo produce componenti ripetibili e conformi a requisiti di sicurezza, durata e integrità strutturale.
L’uso di neutroni provenienti da sorgenti come HFIR consente di:
-
verificare in profondità se il componente stampato presenta cricche interne, porosità non intercettate da radiografia X tradizionale o tomografia a raggi X;
-
misurare la distribuzione tridimensionale delle tensioni residue, elemento chiave per la resistenza a fatica;
-
confrontare diversi set di parametri LPBF o DED sulla base di dati sperimentali, anziché solo su simulazioni.
Un filone in forte crescita è la combinazione tra modelli numerici di processo e misure neutroniche. Le simulazioni di deposizione strato-su-strato vengono calibrate con dati ottenuti su distorsioni e tensioni residue, in modo da poter prevedere il comportamento di geometrie più complesse senza dover testare ogni variante in modo sperimentale.
Sicurezza operativa e gestione degli esperimenti al HFIR
Il funzionamento dell’HFIR si basa su un impianto di sicurezza multilivello. Gli operatori del reattore provengono spesso dal programma nucleare della US Navy e hanno una formazione specifica sulla conduzione di reattori di ricerca. A loro si affiancano esperti di radioprotezione e sicurezza impiantistica, che analizzano condizioni operative, livelli di dose, configurazioni di esperimento e rilasciano le necessarie autorizzazioni.
Ogni ciclo di combustibile prevede una fase di piena potenza, seguita da un arresto per il rifornimento del core e la gestione delle posizioni di irraggiamento. In queste finestre temporali, i materiali già irraggiati – inclusi eventuali componenti additivi – vengono rimossi, confezionati e avviati alle successive fasi di analisi post-irraggiamento oppure ad attività di produzione isotopica. Nuovi campioni possono essere installati per il ciclo successivo, con una pianificazione che deve tenere conto di vincoli di sicurezza, spazio nel core e richieste dei diversi gruppi di ricerca e utenti industriali.
Espansione della Cold Guide Hall e nuove opportunità per i materiali additivi
ORNL sta portando avanti un programma di upgrade dell’HFIR che include il rimpiazzo del riflettore in berillio e il rinnovamento del vessel di pressione, oltre a progetti per estendere e modernizzare la Cold Guide Hall, la zona in cui si concentrano diversi strumenti dedicati ai neutroni freddi.
L’estensione della Cold Guide Hall è pensata per:
-
ospitare nuovi strumenti neutronici orientati alla caratterizzazione avanzata di materiali, inclusi componenti stampati in 3D;
-
migliorare la configurazione degli strumenti esistenti, ottimizzando la geometria delle guide e la qualità del fascio;
-
creare spazio per strumenti dedicati in modo specifico a materiali ad alta prestazione per aerospazio, energia e impiantistica chimica, dove la produzione additiva è sempre più considerata una tecnologia chiave.
In prospettiva, l’accoppiata tra HFIR (neutroni stazionari ad alta intensità) e Spallation Neutron Source (neutroni impulsati) dovrebbe offrire a ricercatori e industrie un pacchetto integrato di tecniche per seguire l’intero ciclo di vita di un componente additivo: dalla progettazione, al processo di stampa, alla qualifica strutturale sotto carico.