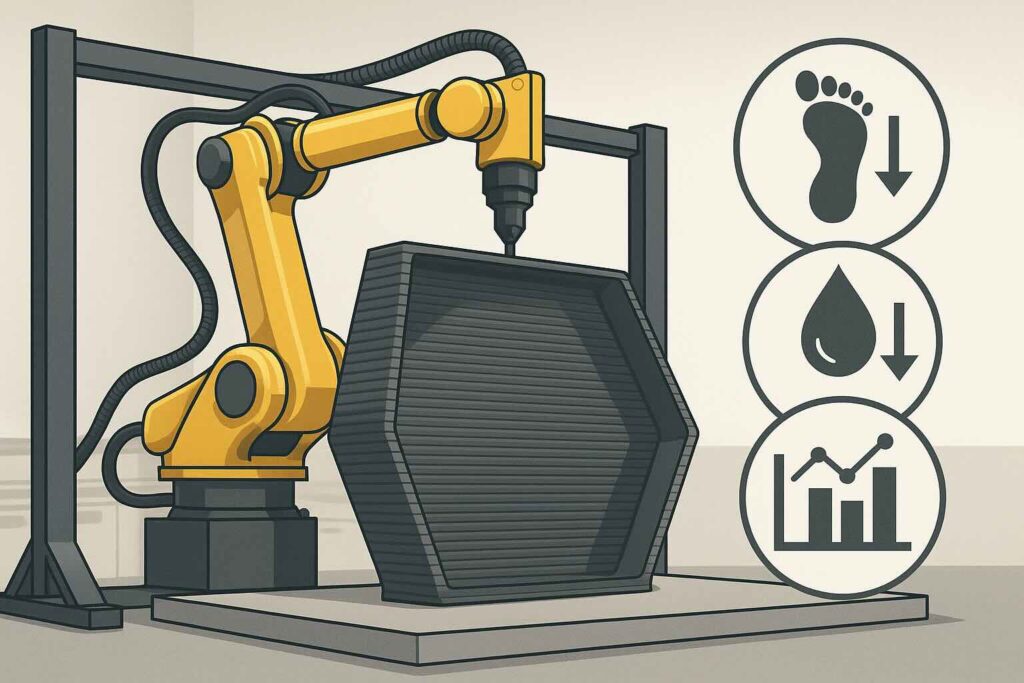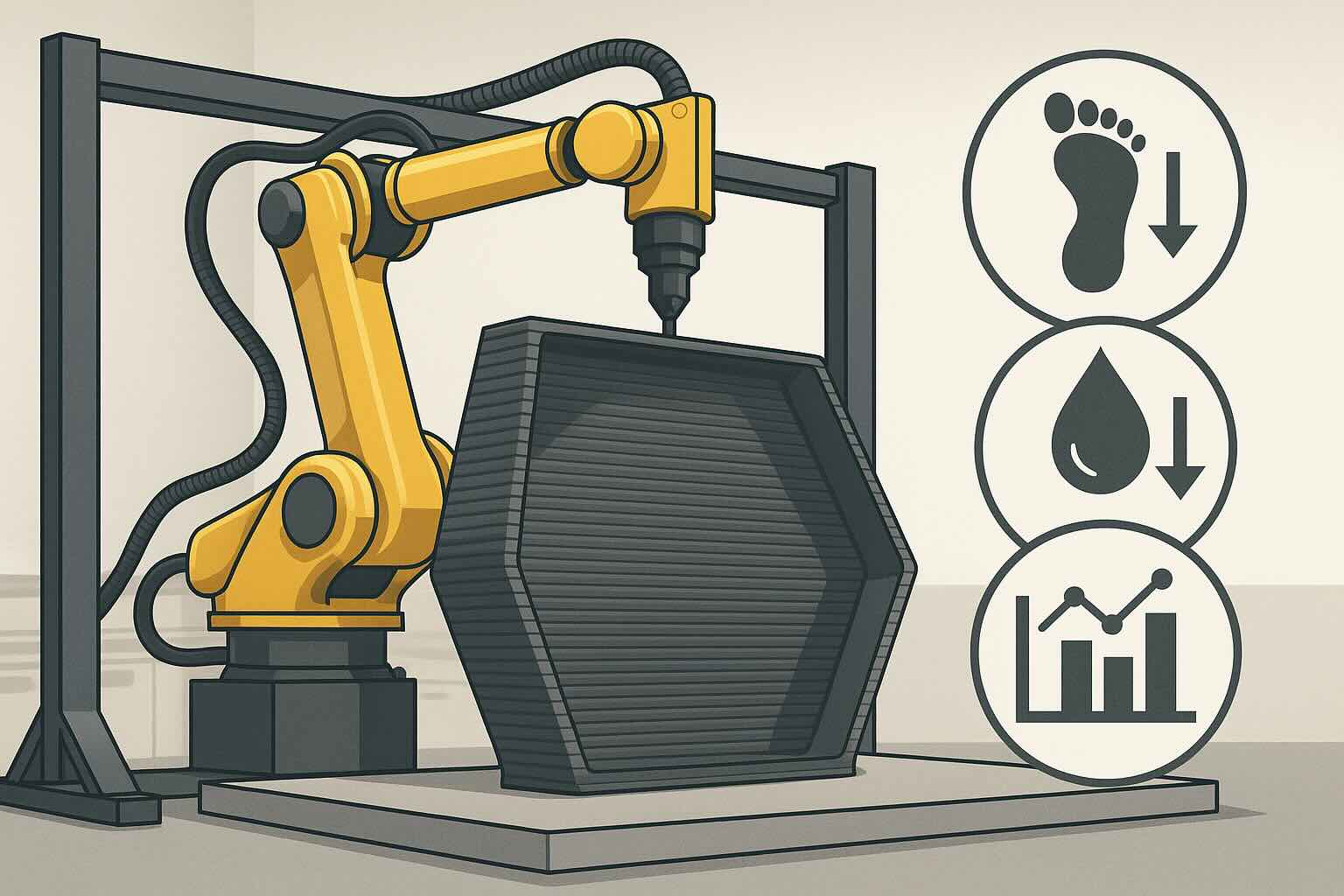Contesto e obiettivi della ricerca
Un gruppo di ingegneri e ricercatori dell’Università di Tampere, di Cranfield, della University of Jaffna e della Technical University of Denmark ha sviluppato un metodo di progettazione computazionale che mette a sistema efficienza strutturale e sostenibilità ambientale nell’ambito della stampa 3D su larga scala (LAAM). L’obiettivo è offrire ai progettisti la possibilità di valutare contemporaneamente variabili meccaniche, consumi energetici, uso di materiale e impatti ecologici lungo tutto il ciclo di vita del componente, dalla formulazione del feedstock alla messa in opera.
Workflow e strumenti software coinvolti
La procedura inizia con la definizione del modello CAD in SOLIDWORKS e la sua analisi in AbaqusCAE, per verificare resistenza e deformazioni in condizioni di carico. Successivamente, ModeFRONTIER orchestra l’intero processo di ottimizzazione multi-obiettivo, integrando i dati di simulazione con ORNL Slicer 2 per la preparazione del percorso di stampa e con Fusion 360 per l’esplorazione di geometrie tramite design generativo. A guidare la ricerca delle soluzioni ottimali è l’algoritmo genetico NSGA-II, che non privilegia un singolo criterio ma classifica i progetti in base alla qualità complessiva della frontiera dei risultati.
Caso di studio: guscio di stampo per pale eoliche
Per dimostrare l’efficacia del metodo, i ricercatori hanno applicato il framework alla realizzazione di segmenti di stampo per pale di turbine eoliche realizzati in termoplastica rinforzata con fibre. Il modello di riferimento è stato sottoposto a un carico di pressione di 160 kPa, verificando un fattore di sicurezza minimo pari a 3 e uno spostamento massimo di 5 mm. Sono stati generati oltre 2.000 progetti CAD con varianti parametriche differenti, valutando per ciascuno il consumo di energia durante la stampa, l’energia incorporata nel materiale e gli indicatori di carbon footprint e water footprint.
Valutazione dell’impatto ambientale
L’analisi “cradle-to-gate” considera tutte le fasi dalla produzione della materia prima al trasporto su strada, stimato in 500 km con camion EURO 4, fino al processo di deposizione. Per la conversione del consumo elettrico è stato adottato un fattore di intensità carbonica di 0,3 kgCO₂ per kWh e un fattore di energia primaria di 0,38. La water footprint è stata calcolata usando un valore di 1,308 litri per terajoule. Gli studiosi hanno osservato che la water footprint può variare sensibilmente in funzione dell’ubicazione degli impianti di estrazione e del metodo produttivo del polimero.
Confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro
I progetti rinforzati con fibra di carbonio hanno garantito rigidezze superiori e deformazioni contenute, ma il peso aggiuntivo della fibra ha comportato un aumento delle emissioni fino a quattro volte rispetto alle varianti con fibra di vetro e un raddoppio dell’uso d’acqua. Per esempio, un componente in ABS con 20 % di fibra di vetro ha mostrato un’impronta carbonica di circa 1.940 kgCO₂e e una water footprint di 174 m³, mentre un elemento simile in ABS con 20 % di fibra di carbonio ha superato gli 8.300 kgCO₂e e i 346 m³. I progetti più leggeri hanno confermato la correlazione lineare tra massa e impatto ambientale, sottolineando come la riduzione del peso sia la leva principale per migliorare la sostenibilità.
Prospettive di utilizzo e sviluppi futuri
Sebbene il test sia avvenuto nella produzione di stampi per pale di turbine eoliche, il framework è estendibile a settori quali l’aerospazio, la cantieristica navale e gli stampi per l’industria automobilistica. I ricercatori suggeriscono di integrare nei software di generative design vincoli di manufatturabilità – come dimensione minima delle feature o orientamento ottimale del pezzo – per evitare geometrie impossibili da realizzare. Ulteriori studi potrebbero combinare controllo parametrico e design generativo, agevolando la nascita di componenti leggeri, performanti e con impatto ambientale ridotto.