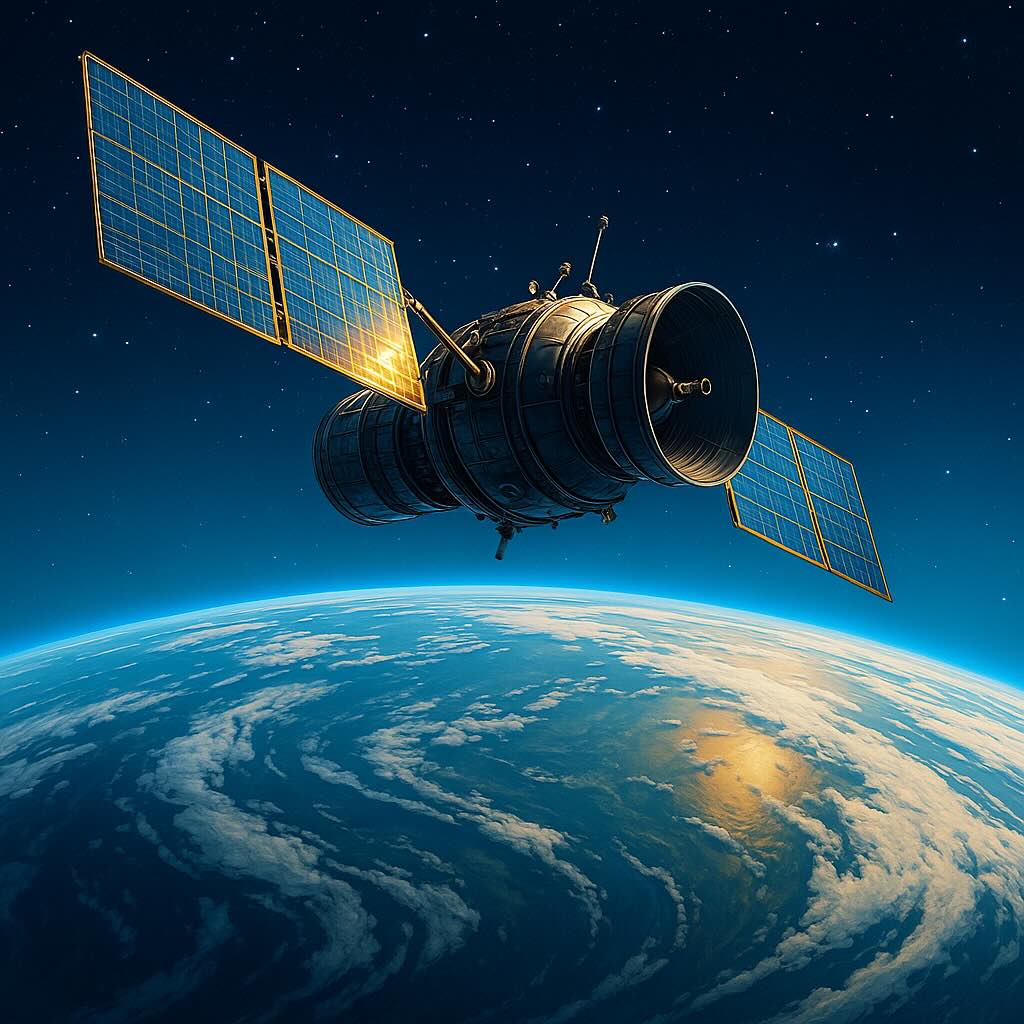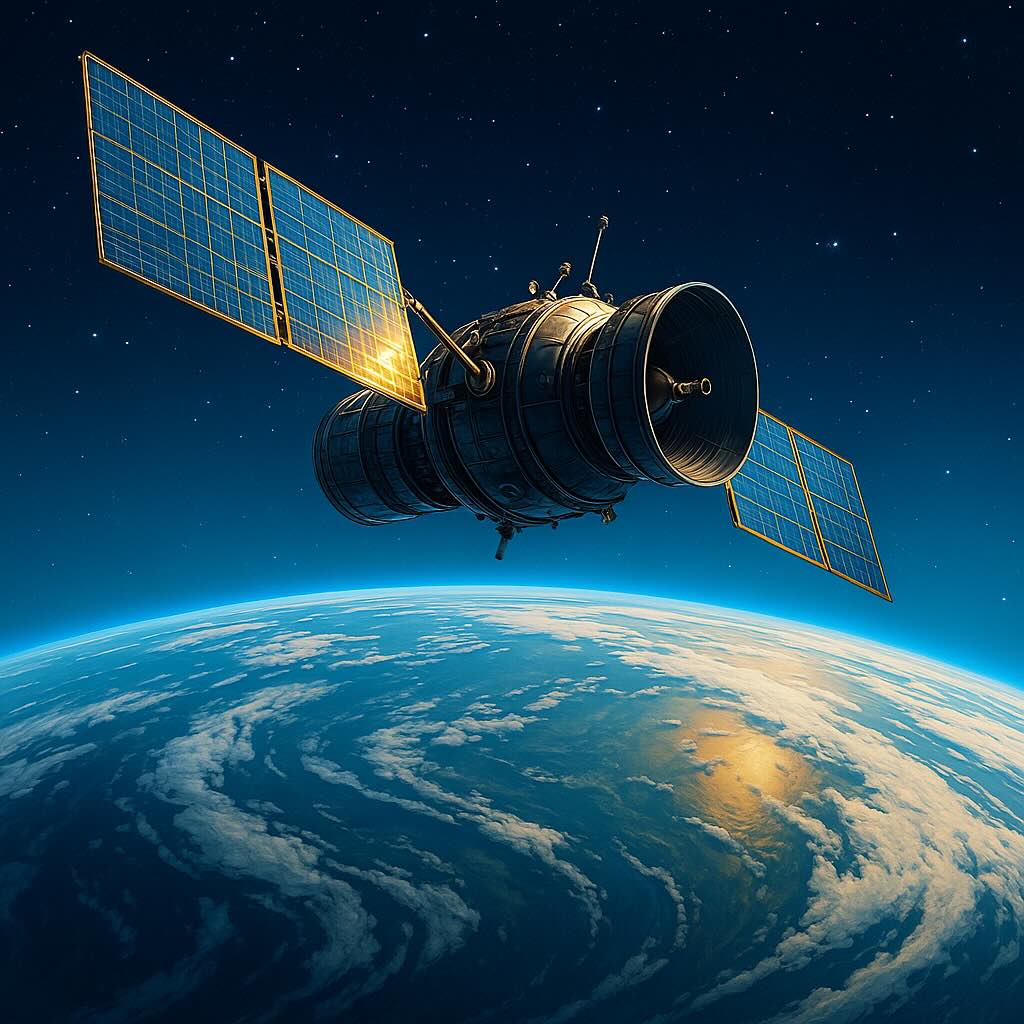Trasformare i detriti orbitali in componenti solidi
Un gruppo di ricercatori guidato da Baylor University e da CisLunar Industries ha messo a punto un processo integrato per recuperare alluminio da materiali di scarto presenti in orbita e ricavarne parti meccaniche a piena densità, adatte sia a impieghi orbitanti sia lunari. Il metodo prevede due fasi principali: fusione elettromagnetica continua del rottame, seguita da deposizione a stir friction additive con doppio filo (TR-AFSD).
Fusione elettromagnetica senza contatto
Il Modular Space Foundry di CisLunar Industries sfrutta il riscaldamento per induzione e il posizionamento elettromagnetico per aggregare e fondere particelle di alluminio senza bisogno di utensili meccanici. In test condotti in volo parabolico, il sistema ha prodotto barre di lega AA6061 dal diametro di 12,7 mm, prive di fusioni tradizionali, pronte per la fase di deposizione additiva.
Deposizione solida a frizione controllata
Nel secondo stadio le barre vengono alimentate offset in un utensile rotante, che genera calore per effetto attrito e ammorbidisce il materiale, estrudendolo strato dopo strato senza superare la temperatura di fusione. Grazie alla configurazione “twin-rod” si ottengono velocità di deposizione elevate e geometrie precise. Nel test descritto nello studio i ricercatori hanno creato un campione bilayer largo 27 mm, lungo 50 mm e spesso 1 mm, depositato su un substrato in AA6061-T6.
Microstruttura e qualità dei pezzi
Analisi tomografiche hanno evidenziato una porosità residua pari allo 0,016 % nel volume lavorabile, contro lo 0,63 % delle barre originali. I vuoti più grandi, fino a 16,5 mm³, erano confinati nei bordi rimossi durante la lavorazione finale. L’esame al microscopio elettronico ha mostrato una frammentazione degli inclusi (ossidi e intermetallici Fe-Si), con una riduzione media della dimensione delle particelle del 91 % (da 34,7 µm² a 3,1 µm²). In parallelo, la grana cristallina si è raffinata da 112,9 µm a 3,7 µm, configurazione che promette un incremento della resistenza meccanica tramite l’effetto Hall–Petch.
Vantaggi per l’approvvigionamento in situ
Secondo i dati dell’Agenzia Spaziale Europea, in orbita vi sono oltre 35.000 oggetti di dimensioni maggiori di 10 cm, elementi che rappresentano un rischio ma anche una risorsa. L’approccio solid-state elimina la necessità di processi a fuso tradizionali e di nuovi leganti, riducendo significativamente i consumi energetici. Si apre così la strada a un modello di riciclo circolare, in cui i componenti di scarto diventano feedstock immediatamente utilizzabili per la produzione di utensili e strutture in ambienti privi di atmosfera.
Applicazioni pratiche e prototipi
Tra gli esempi di parti realizzate con TR-AFSD figurano una chiave da 10 mm, un’impugnatura per bisturi conforme agli standard ISO e una sonda chirurgica, tutti ricavati da AA6061 miscelato con il 10 % in peso di simulante di regolite lunare. Questi oggetti confermano la fattibilità di produrre strumenti essenziali direttamente in orbita o su superfici planetarie durante missioni prolungate.
Prospettive di sviluppo e sfide
Uno degli ostacoli individuati è la necessità di pre-lavorare le barre di fusione prima della deposizione. Gli autori puntano a integrare casting e stampa in un’unica linea continua per snellire l’intero flusso produttivo. Verranno inoltre eseguiti test di trazione e fatica per valutare le prestazioni meccaniche dei pezzi in condizioni reali di opera.
Effetti di microgravità e simulazioni avanzate
Studi futuri indagheranno l’influenza del vuoto, delle radiazioni e della microgravità sui gradienti termici e sull’evoluzione di difetti durante la deposizione. Verranno impiegati modelli numerici come lo smoothed particle hydrodynamics per collegare processo, microstruttura e proprietà finali. Tecniche alternative di elaborazione meccanica-termica come ShAPE (Shear Assisted Processing and Extrusion) potrebbero offrire percorsi senza casting.